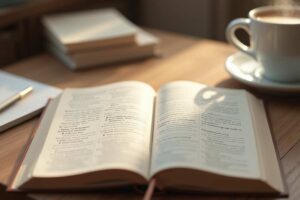Torre di Chia, l’ultima dimora di Pasolini, acquisita dallo Stato come bene pubblico
Un patrimonio culturale carico di significati letterari e storici torna sotto il controllo pubblico: la Torre di Chia, nota anche come la “Torre di Pasolini”, diventa un bene dello Stato dopo una lunga contesa legale. Il complesso monumentale situato nel territorio di Soriano nel Cimino, nel viterbese, fu l’ultima dimora di Pier Paolo Pasolini, il celebre poeta, regista e intellettuale italiano. La sua acquisizione da parte degli eredi e la successiva vendita avevano suscitato un acceso dibattito, con l’Università agraria di Chia che reclamava la proprietà come parte del patrimonio collettivo. Ora, il commissario agli usi civici del Lazio ha sancito la natura pubblica della torre e dei terreni circostanti, annullando l’ultimo atto di vendita, anche se il proprietario ha già annunciato ricorso.
La Torre di Chia: storia e valore culturale
Il complesso, conosciuto ufficialmente come Castello di Colle Casale, è composto da una dimora con un caratteristico tetto di vetro che illuminava lo studio di Pasolini, una torre alta e sottile visibile dalla strada ma non abitabile, e da imponenti mura difensive. Questa fortezza medievale faceva parte del sistema difensivo degli Orsini, signori di quelle terre, posizionate tra l’Umbria e il massiccio del Cimino. Nel XIII secolo, il territorio era proprietà di Niccolò III, papa noto anche per la citazione di Dante nel “pozzo dei simoniaci”. Durante il Rinascimento la tenuta passò di mano tra Vicino Orsini, fondatore del Sacro Bosco di Bomarzo, i duchi Lante della Rovere e infine ai Borghese nel XIX secolo.
La regione in cui si trova la torre è ricca di necropoli etrusche e tombe longobarde, un luogo dove il silenzio e la storia si fondono in un’atmosfera senza tempo. Pasolini, innamorato di questi luoghi, li descrisse con parole intense nelle sue opere, immaginando di vivere e scrivere all’interno di questa dimora, che lui definiva “casa di luce”. Proprio grazie all’intervento della sua grande amica Maria Callas, Pasolini riuscì a comprare la torre nel 1967, nonostante fosse in condizioni di quasi rudere. La cantante lirica, celebre soprano riconosciuto come “la Divina”, pare abbia convinto il proprietario, riluttante a vendere, a cedere la proprietà.
Il valore simbolico e culturale della Torre per Pasolini
La torre fu per Pasolini un rifugio creativo e un punto di riferimento stabile per le sue incursioni nei paesi limitrofi, dove ancora oggi gli anziani ricordano con affetto la presenza del poeta. Tra gli aneddoti tramandati vi sono le sue visite ai locali, le riunioni politiche, le partite di calcetto e persino l’installazione di nani da giardino nel piazzale della torre. Qui Pasolini scrisse importanti opere come “Petrolio” e “Lettere luterane”. La dimora gli ricordava probabilmente il castello dove si rifugiò il frate agostiniano, figura chiave della Riforma, che affascinava il regista per la sua dimensione mistica e rivoluzionaria.
Numerosi sono i legami artistici della torre con l’attività di Pasolini: qui furono girate scene di film come “Il Vangelo secondo Matteo” e “Medea”. Inoltre, il fotografo Dino Pedriali immortalò Pasolini in un servizio che ancora oggi è considerato una delle immagini più potenti e controverse del regista, raffigurato nudo, in una posa di grande intensità.
Il borgo di Chia, piccolo e raccolto, custodisce un monumento dedicato al poeta con un volto scolpito e una frase che ne sintetizza l’essenza: «La verità non sta in un solo sogno, ma in molti sogni». Un simbolo che lega il passato letterario alla comunità presente, senza attrarre un turismo di massa ma mantenendo vivo il ricordo.
Il ritorno della Torre di Pasolini al patrimonio pubblico
Dopo la morte di Pasolini, la torre era rimasta in possesso degli eredi che nel 2020 decisero di metterla in vendita. Nel 2021 l’immobile fu acquistato dal produttore cinematografico Pietro Valsecchi, che lo rivendette due anni dopo all’attore Gabriele Gallinari, noto per ruoli in serie televisive italiane come “Don Matteo” e “Montalbano”. Gallinari, dopo l’acquisto, raccontò di aver avuto un sogno in cui Pasolini gli sorrideva mentre passava con la sua Alfa Romeo, interpretando tale visione come un “nulla osta” al possesso.
Tuttavia, l’Università agraria di Chia, ente che gestisce le terre di proprietà collettiva donate agli abitanti nel XIX secolo dai Borghese, ha avviato una lunga battaglia legale per rivendicare che la torre e i terreni fossero parte del patrimonio collettivo e quindi non alienabili. Grazie a complesse ricerche storiche, il commissario agli usi civici del Lazio, Antonio Perinelli, ha riconosciuto la natura demaniale collettiva dei terreni, annullando la vendita.
Gianluca Inverni, presidente dell’Università agraria di Chia, ha espresso soddisfazione e emozione per questo risultato: «Se la sentenza sarà confermata, intendiamo valorizzare la Torre Pasolini a beneficio della comunità locale, con l’idea di realizzare un museo». La prospettiva è quindi quella di trasformare la torre in un luogo aperto al pubblico, capace di preservare la memoria storica e culturale legata a Pasolini e al territorio.
Pasolini e Maria Callas: un legame artistico e umano
Il rapporto tra Pier Paolo Pasolini e Maria Callas non si limitò alla semplice amicizia, ma fu un intreccio di influenze artistiche e umane. La Callas, soprano di fama mondiale che rivoluzionò il bel canto italiano, fu determinante nell’acquisto della Torre di Chia da parte di Pasolini. La loro amicizia rappresenta un curioso e significativo capitolo nella storia culturale italiana del Novecento, unendo la grande poesia e il cinema di Pasolini con la musica lirica di Callas.
Maria Callas, nata a New York nel 1923 da famiglia greca, è stata una delle figure più importanti della storia dell’opera, capace di riscoprire e valorizzare il repertorio italiano dell’Ottocento. La sua influenza sul mondo della musica e della cultura è tuttora enorme, e il suo supporto a Pasolini contribuisce a mantenere viva la memoria di entrambi.
Il ritorno della Torre di Chia al patrimonio pubblico rappresenta quindi non solo un atto di tutela di un bene culturale, ma anche il riconoscimento di un luogo simbolo di un capitolo fondamentale della cultura italiana, legato a due grandi personalità artistiche che hanno contribuito a definire l’identità culturale del paese.